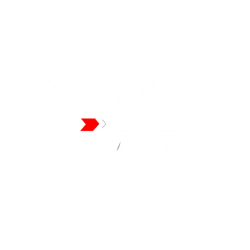STRESS DA MANCATA RISPOSTA
Lo stress da “mancata risposta” è uno degli elementi più comuni della vita di tutti, un aspetto della qualità della vita, professionale e personale, sostanzialmente non indagato.
In questo articolo il fenomeno viene osservato e indagato utilizzando chiavi di lettura distintive della Sistemica del Comportamento Umano, attraverso cui è possibile individuare puntualmente le molteplici sorgenti che alimentano lo stress, riuscendo così ad ottenere una comprensibile e pratica descrizione dei possibili antidoti.
Tra gli antidoti si trova anche la “semplice” conoscenza del meccanismo stressogeno, per questo motivo vengono proposte descrizioni sufficientemente articolate di ciò che è indispensabile sapere per collocare questo spiacevole e comune fenomeno nel quadro delle umane necessità vitali.
Le parole chiave sono: allineamento, conferma di buon funzionamento, egoismo genetico, abbandono, svalorizzazione, colpa e aiuto.
Non risponde…
Succede di scrivere a qualcuno che conosciamo, che abbiamo frequentato almeno un poco per qualche ragione, e che, stando a quanto ci risulta, dovrebbe essere ragionevolmente ben disposto verso di noi.
Oggi è facilissimo inoltrare messaggi attraverso uno qualunque dei numerosi mezzi di cui disponiamo… certo non lettere o biglietti, scritti a mano, con più o meno bella calligrafia, le tastiere hanno pervaso il nostro mondo quotidiano, conferendo ai nostri messaggi il nitore e la precisione di eccellenti macchine da scrivere e la neutralità di una grafia schiacciata nella eleganza standard dei caratteri tipografici.
E succede che colui, colei, coloro a cui scriviamo, semplicemente, non diano cenno di risposta.
Eppure, per quanto ci risulta, non ci sono motivi per non ottenere, in tempi ragionevoli, un cenno, se non qualcosa di più… ma il silenzio è tra le possibilità, e quando accade, naturalmente, interroga.
A volte scopriamo che non si tratta di nulla di grave, che il silenzio ha una ragionevole spiegazione, un temporaneo malessere, un disguido, qualche server che cade, una ditata inavvertita sull’aggeggio che cancella il segnale della nostra bussata…
A volte abbiamo la piena evidenza che l’unica possibile risposta è quella che ci piace meno: il nostro interlocutore ha ben chiaro che lo abbiamo cercato, chiamato, invocato, e, tuttavia, non risponde, non si muove, nessun cenno, nulla.
Sciogliere il dubbio può richiedere tempo, qualche ora, qualche giorno, qualche settimana… e mentre il tempo passa accadono cose, a mio avviso, interessanti.
Eliminiamo i casi in cui la mancata “risposta” è generata da disguido, temporaneo malessere, guasto meccanico… anche se non è poi così facile sbarazzarsene, dato che, ragionevolmente, conserviamo di frequente il dubbio che si tratti di “scuse” più o meno ben congegnate e presentate
Insomma, chiamiamo qualcuno o scriviamo a qualcuno, qualcuno a cui crediamo di poterci rivolgere ragionevolmente certi di ottenere una rapidamente un cenno, una risposta, i mezzi di connessione odierni offrono addirittura la possibilità è di ottenerla quasi immediatamente: invece niente, silenzio.
Se da un lato ha la sua rilevanza pratica cercare di sapere perché ‘sto bastardo non risponde, dall’altro rischia di passare per ovvio il fatto assai comune che noi ne siamo dispiaciuti, o poco o tanto in questo momento non è importante: la traccia che vorrei seguire è proprio questa, il dispiacere che si accompagna alle non-risposte che riceviamo.
Le risposte comuni
Se chiediamo la ragione di tale assai comune dispiacere, le risposte che comunemente otteniamo, e che daremmo probabilmente anche noi, si presentano come varianti di
- Preoccupazione per il nostro benessere: il nostro interlocutore era atteso aiutarci, in qualche modo, ed evidentemente il fatto che non risponda non è di aiuto
- Preoccupazione per la condizione del nostro interlocutore: salute, affetti, affari… oppure un repentino, inatteso e a noi inspiegabile mutamento della sua disposizione nei nostri confronti
Per quanto ci sforziamo di raccogliere esempi, non potremo facilmente trovare reperti diversi; la differenza, tra i due generi di risposte, sembra evidente ed inconfutabile: in un caso si tratta di qualcosa di spiacevole che succede a noi, o che ci aspettiamo che succeda (non riceviamo o non riceveremo l’aiuto sperato), nell’altro si tratta di qualcosa di (tendenzialmente) spiacevole che è accaduta all’altro, e che ha avuto per conseguenza il fatto che non ci ha risposto, non ci ha richiamato.
Una riguarda direttamente noi, l’altra riguarda direttamente l’altro, e poi, solo in seguito, forse, indirettamente noi.
Nel primo caso, anche se siamo disposti a scavare, ad interrogarci, a riflettere, sembra ci sia abbastanza poco da scavare, interrogarsi o riflettere: l’aiuto non ricevuto si accompagna al permanere della condizione che ci ha motivato a chiamare, condizione per qualche aspetto spiacevole per chi ha chiamato, o scritto, non ci interessa qui sapere quale tipo di spiacevolezza sia.
Potremmo concludere che il dispiacere si accompagni più al permanere della condizione spiacevole che al fatto che l’altro non abbia risposto, cosa che comunque non ci sfugge, e che comunemente, viene “spiegata” con la seconda variante.
Insomma, sono in una condizione spiacevole, chiedo aiuto, non lo ottengo, e così le cose spiacevoli diventano due: una è quella di partenza, che permane, l’altra è che l’altro non si è fatto vivo…. che cosa gli sarà successo?
Quasi sempre, in queste condizioni, ci arrangiamo in qualche modo, e, quasi sempre troviamo una soluzione alternativa: eliminiamo cioè la spiacevolezza della condizione in cui ci trovavamo quando abbiamo chiesto aiuto, intervenendo sull’ambiente, che ora presenta una configurazione non più spiacevole.
La riprova che la preoccupazione che riguarda direttamente l’altro è presente anche nella prima variante di risposte che abbiamo indicato, ora si mostra chiaramente: un problema l’abbiamo risolto, l’ambiente è stato normalizzato, ma la questione della mancata risposta dell’altro è ancora, spiacevolmente, sul tavolo.
Dobbiamo prendere in esame la seconda variante, la preoccupazione per la condizione del nostro interlocutore: salute, affetti, affari… oppure un repentino, inatteso e a noi inspiegabile mutamento della sua disposizione nei nostri confronti
Vediamo che cosa siamo capaci di farne: cercando di trovare elementi che meglio spieghino come mai, in genere, per noi sia spiacevole nutrire preoccupazioni di questo tipo, cioè direttamente riguardanti l’altro, quando l’altro sia uno degli elementi della classe dei soggetti “che conosciamo, che abbiamo frequentato almeno un poco per qualche ragione, e che, stando a quanto ci risulta, dovrebbe essere ragionevolmente ben disposto verso di noi”
È facile immaginare che, se ricorressimo alla tecnica dell’inchiesta, nell’ipotesi migliore otterremmo occhiate un po’ diffidenti, nella peggiore un rapido allontanarsi allarmato del candidato da intervistare: come mai è spiacevole non ricevere risposta o cenno da mariti, mogli, figli, genitori, parenti, amici, buoni vicini e conoscenti, colleghi leali, partner professionali fidati?
Del tutto evidente ed ovvia l’insensatezza del chiedersi la ragione della preoccupazione che si accompagna alla mancata risposta di uno qualunque di loro: sono le persone realmente importanti nella vita di ciascuno di noi, emotivamente, affettivamente, socialmente, spesso anche praticamente…
È innegabile che anche per noi le cose stiano proprio così, quelle sono certamente le persone realmente importanti, hanno con noi legami forti, è ovvio che siamo personalmente toccati da ciò che accade loro, e dunque ovvio che, quando non ci rispondono, almeno un po’ ci preoccupiamo… mica vorremo inoltrarci negli impenetrabili rovai della natura dei legami sociali, dei legami affettivi, dell’empatia, della genitorialità, vero?
Resistendo alla tentazione di rinunciare ad una ricerca che sembra sempre meno promettente, e cercando di stare alla larga dai rovai prima indicati, non ci è tuttavia possibile spiegarci questa ovvietà evitando di chiamare in causa la natura dei legami che, per ciascuno di noi, distinguono le persone care al nostro cuore, per così dire, dalle altre: la definizione stessa di importanza di questa o quella persona si porta dietro, sembra inevitabilmente, la caratteristica di connotare la nostra relazione con quella persona come importante.
E le comuni definizioni di importanza attribuita alle relazioni si portano dietro la cifra della ovvietà delle preoccupazioni che sorgono allorquando non otteniamo da loro pronta e solerte risposta, non meno della ovvietà di dispiaceri, a volte anche molto intensi, collegati ad un andamento negativo della nostra relazione con loro: loro stanno bene, ma la relazione con noi è burrascosa, e noi, “ovviamente” ne soffriamo, oppure la nostra relazione è salda, sicura, aperta e affettuosa ma loro non stanno bene, qualche guaio li riguarda, e anche in questo caso, “ovviamente” ne soffriamo.
Se da un lato non possiamo che inchinarci ed accettare la ovvietà, la inevitabilità di questi modi di darsi a noi della natura della importanza, di ciò che è importante, dall’altro vediamo almeno due possibilità: possiamo arrenderci anche noi alla importanza della ovvietà, e cessare di interrogarci più a lungo su questo comune aspetto della nostra vita quotidiana, oppure possiamo, in un certo senso, sfidare l’ovvietà che ci chiude il passo, e tentare di proseguire.
Prendendo congedo da coloro che qui decidono di fermarsi, augurando loro ogni bene ed ogni fortuna, riprendiamo alcuni punti che abbiamo imbastito sin qui.
Cui prodest
Ci siamo spiegati il dispiacere della mancata risposta ad una chiamata come correlato al dispiacere che proviamo quando la chiamata è mirata ad ottenere aiuto e l’aiuto non arriva, e solo residualmente come correlata alle condizioni, per il momento a noi ignote, in cui si trova colui o colei che è membro della classe dei soggetti “cui crediamo di poterci rivolgere ragionevolmente certi di ottenere rapidamente un cenno, una risposta”.
Per dirla ricorrendo ad un antico topos, la risposta che ci siamo dati ha a che fare principalmente con un vantaggio atteso, con una utilità per noi, insomma con il cui prodest, a chi (e a che) giova: qualcosa del nostro ambiente si manifesta come spiacevole (caratteristica che emotivamente indica una configurazione tendenzialmente minacciosa per la nostra buona sopravvivenza), l’aiuto dell’altro è atteso rimuovere ciò che ci disturba, puntando a ripristinare la precedente condizione di benessere.
Trattandosi di persone membri della classe dei soggetti “che conosciamo, che abbiamo frequentato almeno un poco per qualche ragione, e che, stando a quanto ci risulta, dovrebbe essere ragionevolmente ben disposti verso di noi”, abbiamo anche riconosciuto che, normalmente, anche quando la nostra situazione è stata normalizzata senza il loro intervento, ci resta una preoccupazione più o meno vaga, più o meno intensa, circa le loro condizioni.
Questa seconda fonte di dispiacere ce la potremmo rendere intellegibile di nuovo ricorrendo al cui prodest, più o meno: per questa volta ce l’ho fatta, ma potrebbe succedere qualcosa di analogo o di nuovo in cui il suo aiuto è indispensabile. Ci preoccupiamo dunque ancora di noi stessi, dislocati in un futuro più o meno vicino o remoto, anticipando ora il dispiacere che ci toccherebbe affrontare nel caso, di nuovo, non ottenessimo risposta, e cioè aiuto.
Nel luogo in cui sono nato, tra i detti popolari, se ne trova uno calzante con quanto stiamo elaborando: il bene viene dall’utile.
Questo detto era utilizzato per schernire e disapprovare chi dimostra considerazione e affetto solo a coloro che visibilmente gli sono utili o possono risultare utili in relazione agli affari, al denaro: la disapprovazione è rivolta contro questa logica strumentale, volendo in generale valorizzare l’autenticità e la positività degli affetti “veri”, quelli generosi e disinteressati, su cui si può fare sempre affidamento.
Molte sono le prove che potremmo portare, prove che rendono inconfutabile che la nostra preoccupazione può anche essere alimentata da un sincero e “disinteressato” interesse per l’altra persona.
Molte sono le prove che, in completa buona fede, crediamo di poter portare per sostenere che il nostro agire può essere mosso non già da un nostro personale ed egoistico tornaconto, ma da impulsi che in genere non esitiamo a riconoscere come generosi, disinteressati, altruisti; modi di agire e tipi di azione che anzi presentano proprio la caratteristica opposta, di costituire evidente danno per sé, impegno di tempo, esborsi di denaro, dispendio di energie, a puro favore dell’altro, con piena evidenza di assoluta assenza di qualunque forma e tipo di “guadagno”.
E senza inoltrarci sul pericoloso sentiero dell’eroismo, restando tra i comuni fatti della vita quotidiana, prendiamo in considerazione una particolare caratteristica che possiamo individuare della situazione in cui chiamiamo qualcuno mossi, non propriamente dal bisogno, ma dalla voglia, dal desiderio di sentire un altro, di avere notizie di un altro: non c’è nulla che gli o le vorremmo chiedere riguardo a qualcosa che ci sta succedendo ora, per averne conforto, consiglio, aiuto, è proprio semplicemente per sapere come sta, come se la sta passando, per stare, più o meno “virtualmente”, un poco in compagnia.
Insomma, quella che potremmo definire una chiamata disinteressata, non ispirata dall’obiettivo di ottenere qualche aiuto o qualche sia pur lontano o remoto vantaggio… sì, riconosco che sono rare, ma sono certo che questa sia una esperienza che ciascuno di noi ha vissuto almeno una volta.
La spiegazione credibile che abbiamo ottenuto, nel caso precedente, dall’utilizzo del cui prodest, in questo caso non possiamo ottenerla: le evidenze dimostrano che non è presente alcun vantaggio, e se nessun vantaggio è dimostrabile, allora non possiamo spiegarci questo comportamento ricorrendo al cui prodest.
E dunque, quale spiegazione possiamo offrire?
A mio sommesso parere, le risposte possibili possono essere trovate seguendo tre diversi sentieri: la poesia, la mistica, e la scienza. Tutti e tre i sentieri condividono la condizione di costituirsi come “dispositivi” che permettono di vedere quel che l’occhio non può vedere, né la mano toccare… e, naturalmente, ciascuno di questi permette di vedere “cose” abbastanza diverse, tra loro a volte non troppo distanti per alcuni aspetti, a volte quasi incommensurabili.
Deluderò necessariamente mistici e poeti, non mi sento per niente sicuro seguendo i loro sentieri: tenterò dunque di seguire il sentiero della scienza, anche se le prime risposte che trovo lungo questo sentiero sono un po’ deludenti.
Ad oggi, a mia conoscenza, non è disponibile, per una adeguata comprensione del comportamento umano, una prospettiva teoretica ed epistemica migliore di quella in buona misura indicata da Darwin, ripresa ed enormemente ampliata, arricchita e approfondita da Freud, integrata da Maturana, prospettiva che non esito a chiamare sistemica. Prospettiva che costituisce, sia pure in misura non ancora completa, un paradigma scientifico.
Ad oggi, il contributo delle ricerche condotte utilizzando questo paradigma nel merito della questione che stiamo cercando di affrontare, è certamente interessante, anche se da estrarre dai lavori di Freud e di Maturana, dato che non se ne sono occupati in modo diretto; interessante ed incompleto, soprattutto a causa di una concezione della identità, della persona che si incardina su una configurazione dell’Io e del cosiddetto psichismo che meritano una profonda revisione.
Revisione che certo non intendo condurre o presentare ora, in parte alcuni elementi li ho presentati in un mio lavoro recente, e me ne occuperò a fondo in un lavoro successivo: ma anche scansando ora la puntuale indicazione degli elementi da revisionare, perché ci siano di aiuto e non di ostacolo ad una più piena e profonda comprensione del nostro comune agire, ci è possibile snodare alcune osservazioni partendo da alcune premesse semplificate.
La prima premessa è costituita dalla irrinunciabilità, per continuare ad usare questa locuzione, del cui prodest: locuzione che opportunamente “tradotta” indica uno dei risvolti della piena accettazione della spinta alla sopravvivenza (inclusa la riproduzione, che della sopravvivenza è forma specifica di ogni specie vivente) come motore e della sopravvivenza come fine primo e ultimo di ogni forma e specie vivente.
Tentare di spiegarci il senso della spinta alla sopravvivenza, restando sul sentiero della scienza, ha oggi la stessa probabilità di successo della spiegazione che potremmo cercare del senso del motore energetico di ogni atomo; così come tentare di spiegarci il senso della finalità della sopravvivenza si apparenta al tentativo di spiegarci il senso della (temporanea?) espansione del cosmo e del concomitante aumento progressivo della entropia.
In attesa di nuovi sviluppi della ricerca e della conoscenza scientifica, possiamo ragionevolmente accontentarci della stabilità di questi costrutti, e tentare di basare su questi solidi costrutti le interpretazioni e la conoscenza che possiamo sviluppare del nostro comportamento.
Si tratta dunque di trovare il vantaggio che ciascuno di noi può ottenere agendo in modo affettuoso, partecipe, vicino, e, con piena evidenza, completamente disinteressato.
Credo che tra le prime cose che possono venire in mente ci siano le azioni, i comportamenti dei genitori rispetto ai figli, in genere i primi abbastanza amorevolmente dediti alla cura dei secondi: e di qui invocare il dettato genetico. Insomma, potremmo essere semplicemente “costretti” dalla ereditarietà ad adottare comportamenti altruistici, finalizzati alla continuazione della specie.
Assumendo questa posizione, semplicemente scorrendo i quotidiani, saremmo costretti ad ammettere una elevatissima frequenza di fallimento del dettato genetico, cosa che ci è preclusa dalle solide conclusioni di almeno un paio di secoli di ricerca scientifica; senza tuttavia poter escludere che, a qualche livello di integrazione sistemica, sia geneticamente predisposta una “tensione” alla cura dell’altro, favorendo simultaneamente l’allevamento della prole e l’aggregazione degli organismi in comunità più ampie.
Siamo ancora lontani da una congettura soddisfacente, ma sin qui siamo rispettosi del cui prodest: la ricompensa, naturalmente, è inscritta nell’obbedienza al codice, vediamo se e come riusciamo a procedere.
I codici neurali
Prevengo una possibile obiezione, introducendo una seconda premessa semplificata: qualunque nostro movimento, azione, comportamento, è necessariamente controllato, guidato, sostenuto, orientato, coordinato, da un codice, né più né meno dei movimenti delle macchine a controllo alfanumerico, dei robot insomma, che possiamo vedere all’opera in molte officine moderne.
Come per loro, anche per noi tali codici non vanno considerati “causa” del comportamento, ma solo ed esattamente guide delle sequenze di disposizione degli organi del nostro organismo; diversamente da loro, per noi ha senso parlare di ricompensa, e per qualunque codice geneticamente ereditato la ricompensa è la promessa della sopravvivenza, sopravvivenza “conquistata” dalle generazioni che ci hanno preceduto attraverso il processo di selezione naturale.
Il codice va visto per quello che è, istruzioni che ci guidano nel governare la nostra interazione con gli ambienti con cui abbiamo a che fare, ambienti tendenzialmente in continuo mutamento di configurazione degli elementi e dei sistemi che li costituiscono.
Per tutti gli esseri viventi, e quindi a maggior ragione per noi, è impossibile disobbedire a tali codici: le differenze di comportamento vanno viste per quello che sono, obbedienza a codici diversi.
Come riusciamo a renderci ragione dell’esistenza, a questo punto ovvia, di codici che sostengono un agire disinteressato, dimostrabilmente e dimostratamente contrario al proprio personale ed individuale vantaggio, e quindi in aperta contraddizione con il cui prodest?
Abbiamo già riscontrato la parziale adeguatezza del ricorso al dettato genetico, magari in parte sì, qualcosa c’è che facilita il comportamento “altruista”, che poi sin qui tanto altruista non è, dato che l’allevamento della prole, per la specie, è una attività da sostenere, e l’indice di sopravvivenza sale drammaticamente per le specie sociali rispetto a quelle non sociali: dunque?
Come ci procuriamo l’altro pezzo di spiegazione, restando sul sentiero, ahimè limitato, della scienza?
Potremmo tentare di ricorrere alla classica alternativa alla spiegazione “naturale”: se non istinto (dettato genetico), allora è cultura, educazione: non stiamo temporaneamente rigettando la Sistemica, tutt’altro. Per la Sistemica, ciò che chiamiamo educazione è l’insieme dei tentativi, molti dei quali di successo, di generazione di specifici codici neurali, apparentabili ai riflessi condizionati.
I codici che utilizziamo, insomma i nostri comportamenti, anche e soprattutto quelli sociali, sono giustamente considerati come fortemente correlati alla educazione che abbiamo, o non abbiamo, ricevuto: non credo siano stati condotti studi trasversali sulla educazione di coloro che hanno dedicato e dedicano parte della loro vita ad attività cosiddette di volontariato, almeno a me mancano le conclusioni di tali studi di cui evidentemente non ho traccia.
Ma le poche, semplici e dirette risultanze della mia diretta conoscenza di soggetti con queste caratteristiche e della loro vicenda educativa, mi inducono considerare l‘opzione culturalista come parzialmente insoddisfacente: se scrivo a Marco, Maria, Giovanna, o a mio figlio, tutti soggetti con cui intrattengo una relazione, per così dire, no profit, dedicando a loro qualcosa di me, tempo, energia, denaro, non è solo per dettato genetico “altruistico”, nemmeno aggiungendo a questo dettato l’obbedienza alla educazione che ho ricevuto.
Purtroppo non possiamo considerarci soddisfatti, la spiegazione non è completa, non è completamente soddisfacente.
È che cominciamo a trovarci un po’ a corto di alternative, ora da che parte andiamo? Natura non basta, cultura non basta, che altro resta…. forse la casualità? Anche se plausibilmente la nostra prima reazione a sentir nominare la casualità come spiegazione del nostro scrivere a Marco, Maria e agli altri è perlomeno di perplessità, vale la pena non scartarla immediatamente.
Che la casualità abbia a che fare con Marco, Maria, Giovanna, e anche con mio figlio, non c’è dubbio possibile: come siamo entrati ciascuno nell’ambiente dell’altro dipende da un numero così elevato di intersezioni casuali di serie di eventi causalmente determinati (definizione dell’effetto Cournot), da impedirci di espellere la casualità dal campo di osservazione.
E dunque, che cosa ci impedisce di accettare l’idea che potremmo anche funzionare in modo relativamente casuale, come le slot machine: disponiamo di un numero elevato ma limitato di variabili, e ciascuna combinazione corrisponde all’innesco di un plesso-rete di codici neurali, un giro di manovella, o un pulsante che si preme da sé, girano le ruote, esce una combinazione, ed ecco che scriviamo a Marco.
O varianti meno arbitrarie, ma che lasciano al caso la sua parte, come le cosiddette fuzzy logic…
Mi dichiaro incapace di seguire questo filo di indagine, non ne so abbastanza, anche se avverto uno iato, incolmabile dalle fuzzy logic, tra il nostro tentativo di darci una spiegazione soddisfacente del comportamento disinteressato da un lato, e Marco, Maria, Giovanna (mio figlio) dall’altro.
Cerco quindi di procedere per un sentiero che conosco un poco meglio, anche per cercare di avvicinarci al termine di un divertissement che rischia di diventare troppo lungo, e quindi non più divertissement.
Ambienti reali e ambienti virtuali
Occorre che riconsideriamo l’ambiente entro cui accadono le cose che abbiamo descritto, l’abbiamo certamente fatto, in modo almeno indiretto, ma per procedere ci serve qualcosa di più. Iniziamo da un dato facilmente condivisibile: l’accadimento scrivo-a-Marco-un-sms (una email, un txt, su twitter, facebook, whatsapp…) si produce in un ambiente, in cui posso accedere ai dispositivi di comunicazione che possono consegnare il messaggio ad un destinatario di mia scelta.
Per quanto semplice (ma non poi tanto semplice) questa azione, per poter essere compiuta, richiede di essere, in qualche modo predisposta, progettata e preparata; e di nuovo non è difficile accettare che questa progettazione, questa preparazione, avvenga in una variante dell’ambiente, quella variante costituita da ciò che comunemente chiamiamo la nostra mente: ci pensiamo, ci viene in mente di scrivere a Marco, a Maria, e, più o meno immediatamente dopo, lo facciamo.
Compiamo cioè tutta quella serie di atti che si concludono con il riscontro di “messaggio inviato”. Per la Sistemica gli ambienti in cui viviamo simultaneamente sono sempre almeno due: uno è l’ambiente reale, l’ambiente in cui troviamo i corpi fisici, i fenomeni fisici, l’altro è l’ambiente virtuale, proprietà emergente del nostro sistema neurale.
Rinuncio naturalmente ad una presentazione completa dei due ambienti, limitandomi a indicare che l’unico ambiente realmente virtuale è quello che troviamo, ciascuno di noi, dentro le nostre scatole craniche; la realtà virtuale, detta anche realtà aumentata, è una variante interessante e divertente dell’ambiente reale, anch’essa costituita da elementi fisici.
Utilizzo il concetto di ambiente virtuale (e anche altri, come si vedrà tra poco) per prendere distanza dai rilevanti pericoli connessi all’impiego del concetto di “mente”: il termine risulta eccessivamente sincretico, polisemico, e spesso purtroppo fuorviante, va usato con enorme cautela, e, se possibile, non usato affatto.
Accontentiamoci di elementi più modesti e meglio dominabili: nell’ambiente reale eseguiamo una serie di azioni, azioni progettate e trovate nel nostro privatissimo, inaccessibile ad altri, ambiente virtuale.
Fin qui è facile. Molto meno facile è rispondere alla seguente domanda: chi esegue le semplici azioni descritte? L’ovvia risposta: “Noi!” (o Io!) tanto ovvia non è, anzi, è enormemente complessa.
Io che cosa, io chi..
Tenendo fermo e chiaro il riferimento stabile ai due ambienti, dobbiamo dare due risposte convincenti rispetto ai due ambienti: per semplicità espositiva riferiamoci ad un soggetto agente singolare, cioè un Io.
Per il primo è facile: nell’ambiente reale “Io” identifica uno specifico organismo umano, e dunque, con verità posso affermare che Io, specifico organismo umano, agisco.
Per il secondo ambiente, rispetto all’ambiente virtuale, individuale ed inaccessibile a chiunque, “Io” non è, non può essere lo specifico organismo umano di prima.
Potremmo, con molte ragioni, sostenere che il primo Io, quello dell’ambiente reale, contiene il secondo, una specie di matrioska: questa affermazione tuttavia ci costringe a restare nell’ambiente reale, e a restare assolutamente ciechi rispetto alle straordinarie meraviglie che accadono nell’ambiente virtuale.
L’Io che è contenuto nell’organismo vivente nell’ambiente reale, è un frutto evolutivo estremamente sofisticato: è uno dei sistemi di cui siamo costituiti, e, considerato rispetto all’ambiente virtuale, si costituisce come l’insieme organizzato di tutti i codici (le istruzioni codificate) neurali che abbiamo utilizzato e utilizziamo per governare l’interazione del nostro organismo con l’ambiente reale.
L’Io “sistemico” è un sistema, costituito da organi integrati (sistemi) quando lo guardiamo rispetto all’ambiente reale, costituito da codici neurali integrati quando lo guardiamo rispetto all’ambiente virtuale.
Il funzionamento del nostro sistema neurale resta, ad oggi, per la maggior parte ignoto; lo stesso vale per il codice neurale: ma che entrambi esistano, e che entrambi siano strettamente collegati al nostro buon funzionamento è assolutamente fuori discussione.
L’Io come sistema integrato dei codici neurali che utilizziamo per governare l’interazione tra il nostro organismo e l’ambiente reale in cui ci troviamo è dunque una buona ipotesi: non disponiamo di prove di laboratorio da porgere a dimostrazione della sua “reale” configurazione
In attesa che tali prove (a conferma o disconferma) emergano dalle ricerche dei prossimi secoli, siamo autorizzati (benché a totale nostro rischio e pericolo) ad utilizzare questa ipotesi per renderci comprensibile e spiegabile il contraddittorio fenomeno del comportamento “disinteressato”.
Qualcuno si sarà già inoltrato lungo questo sentiero, impaziente di proseguire, probabilmente calamitato da un paio di conseguenze, implicazioni di questa prospettiva di osservazione: se, nell’ambiente virtuale, l’Io è l’insieme dei codici che usiamo, l’Altro, allora, chi è?
Ovviamente nell’ambiente reale l’Altro, Marco, è quell’organismo là, proprio e solo quello là, unico ed irripetibile: e nell’ambiente virtuale? Dobbiamo fare la stessa operazione che abbiamo fatto con noi stessi? Impossibile, dato che l’Io virtuale dell’Altro è inaccessibile, chiuso nella sua scatola cranica: di lui (o di lei) abbiamo solo gli elementi che abbiamo potuto e possiamo condividere nell’ambiente reale.
Per essere esatti, nelle migliori condizioni disponiamo solamente dei neurogrammi (è il nome sintetico dei codici neurali che abbiamo specializzato per governare ogni specifica configurazione di ambiente reale con cui abbiamo a che fare) relativi a quegli elementi, neurogrammi che insieme costituiscono Marco come uno degli elementi del nostro ambiente reale.
Anche fermandoci qui, molto prima di tentare di comprendere come allora sia possibile costituire l’Altro come soggetto, e non come un oggetto tra gli altri nel nostro ambiente reale, la conclusione cui questo sentiero ci conduce è davanti al nostro naso: se disponiamo solo dei neurogrammi che riguardano Marco, che riguardano gli elementi-Marco condivisi nell’ambiente reale, avendo accettato che l’Io è l’insieme dei neurogrammi che ci aiutano a governare la nostra interazione con l’ambiente, allora Marco, nel nostro ambiente virtuale, è semplicemente una “parte” del nostro Io.
Preferirei che lo chiamassimo, da ora in poi, Sistema Egoico, lasciando l’Io alle nostre conversazioni quotidiane, alla grammatica ed alla sintassi della lingua che preferenzialmente utilizziamo: il vantaggio che otteniamo adottando questo suggerimento è di diminuire vistosamente le possibilità di equivoco e di confusione.
Abbiamo a che fare con sistemi ed ambienti, vediamo come questo può aiutarci a comprendere ciò che osserviamo, meglio di quanto non facciano altre opzioni scientifiche: il nostro Sistema Egoico integra, nel suo funzionamento, certamente anche i neurogrammi che ci aiutano a governare l’interazione con quella particolare e specifica configurazione di ambiente in cui entra in gioco Marco... e che è Marco.
Avere a che fare con Marco nel nostro ambiente virtuale non significa certo mettersi davanti ad uno specchio virtuale, cercando di individuare nel nostro Sistema Egoico i neurogrammi-Marco, come se fossero parti di un costume di Arlecchino: rappresentare noi stessi nel nostro ambiente virtuale come “copie” dei noi stessi che vediamo nell’ambiente reale è la cosa più semplice e spontanea che può “venirci in mente” di fare.
Se seguissimo l’impulso non dovremmo dimenticare, prudentemente, che ciò che sta virtualmente dipingendo la scena nel nostro ambiente virtuale, non la dipinge certo usando tela, colori e pennelli, braccia e mani, o nessuno degli attrezzi che possiamo scovare nei nostri ambienti reali… non lo seguiremo, provando a fare qualche passo nella direzione di una conclusione verso cui è bene avviarsi.
La costituzione dell’Altro come soggetto necessariamente avviene nel nostro ambiente virtuale, ed è un processo complesso, che coinvolge numerosi sistemi, di cui non ci occuperemo ora: più o meno tutti siamo capaci, in misura più o meno ampia di riconoscere ed accogliere un altro come soggetto, e non solo come oggetto vivente nel nostro ambiente.
Coloro che noi consideriamo importanti sono, nel nostro ambiente virtuale, plessi e insiemi di neurogrammi rilevanti e significativi nella nostra storia, per ragioni e motivi che sono scritti nella nostra storia, unica ed irripetibile: la loro esistenza e accessibilità è importante, o per lo meno lo è stata (e quindi potrebbe esserlo nuovamente) in relazione alla qualità della nostra vita, in breve per la nostra sopravvivenza.
Allineare e confermare
Occorre che ora introduca un ulteriore elemento, che riguarda la nostra esistenza simultanea, la nostra vita simultanea nei due diversi ambienti, una sorta di principio guida, di regola di sicurezza: poter disporre di un ambiente virtuale è una ricchezza, evolutivamente parlando, formidabile, costituisce un vantaggio competitivo straordinario.
Nell’ambiente virtuale possiamo manipolare spazio e tempo, possiamo fare esperimenti e prove anche estremamente pericolosi senza farci alcun male, possiamo preparare le azioni che poi dispiegheremo, con successo, nell’ambiente reale, e molto altro ancora: naturalmente c’è un pericolo, rilevante, rispetto a cui, con ogni probabilità, proprio la selezione naturale ha finito per costituire una specie di cintura di sicurezza.
Il pericolo è di eccedere nella “vita virtuale”, nel restare cioè prevalentemente nell’ambiente virtuale, trascurando il governo della interazione con l’ambiente reale: per evitare questa evenienza estremamente pericolosa per la nostra sopravvivenza, siamo dotati di una specie di allarme che scatta quando, oltre un certo limite di tempo, assai variabile da individuo a individuo, ciò che troviamo nell’ambiente reale non corrisponde, non è simile a ciò che simultaneamente troviamo nell’ambiente virtuale.
Come diremmo usando il linguaggio quotidiano, possiamo restare immersi nei nostri pensieri, nelle nostre riflessioni, nello studio di astrazioni matematiche, anche a lungo, ma ad un certo punto meglio dare un’occhiata a che cosa succede là fuori, magari si sta preparando un temporale, ed occuparci di ciò che esiste nei due ambienti.
Non si tratta di un “richiamo alla realtà”, entrambi gli ambienti sono realmente esistenti, ma di un dispositivo di regolazione di attività, memoria geneticamente trasmessa di ciò che hanno appreso le generazioni che ci hanno preceduto, vivente ammonizione: l’elaborazione straordinaria che possiamo sviluppare nell’ambiente virtuale serve, deve servire, a rendere più sicura la nostra vita nell’ambiente reale.
Sistemi di allarme
Gli allarmi umani di questo genere hanno una caratteristica specifica, sono silenziosi e dolorosi, costituiti da spiacevole sofferenza, più o meno intensa: sia pure lieve, il dispiacere accompagna il riscontro di disallineamento tra ciò che troviamo nell’ambiente virtuale e ciò che troviamo, simultaneamente, nell’ambiente reale.
Di contro, il successo relativo nel raggiungere questo equilibrio, finalizzato a rendere sicura la nostra sopravvivenza, è contrassegnato dalla generale soddisfazione (anch’essa può essere di modestissima intensità) che si prova quando ciò che troviamo nell’ambiente virtuale viene “ritrovato” nell’ambiente reale.
È tempo di tirare le somme: la cura disinteressata verso le persone per noi importanti, fino a quando persiste, le perdite che apparentemente sopportiamo (tempo, energia, denaro) fino a quando tale cura disinteressata persiste, sono in verità ricompensate dalla soddisfazione che prova il “curante disinteressato” nel ritrovare nel suo ambiente reale ciò che esiste nel suo ambiente virtuale, elementi e parti importanti di sé, neutralizzando gli strali dolorosi del sistema di allarme anti-squilibrio.
Allarme che evidentemente ha dato segni di entrare in funzione, motivando il soggetto curante (disinteressato) a chiamare, scrivere, insomma fare qualcosa per ottenere conferma della similarità tra le configurazioni degli ambienti virtuali, i buoni neurogrammi all’opera nell’ambiente virtuale, e le configurazioni dell’ambiente reale, di nuovo i buoni neurogrammi questa volta all’opera nell’ambiente reale.
La risposta dell’altro, di questo altro specifico a cui ci rivolgiamo in modo “disinteressato”, ha allora il valore di conferma del proprio buon funzionamento, conferma che ha innegabilmente per noi un grande valore, ben sufficiente a ricompensare gli sforzi dispiegati per ottenerla: cosa che cancella semplicemente l’apparenza “disinteressata” del nostro agire, agire che così chiaramente persegue e ottiene qualcosa che ci serve.
La mancata risposta apre la prospettiva su scenari riparativi o luttuosi, ma possiamo fermarci qui, al riscontro della legittimità del dispiacere che proviamo, concomitante alla mancata risposta, frutto di quell’antico sistema di allarme che avvisa imperiosamente che occorre fare qualcosa, poiché i nostri mondi si sono disallineati, poiché le nostre vite, quella che conduciamo nell’ambiente reale e quella che conduciamo nel nostro ambiente virtuale, non scorrono più in armonia.
O ancora, in altre parole, i nostri buoni neurogrammi, quelli su cui facciamo affidamento per garantirci una buona sopravvivenza, potrebbero non essere più utilizzabili con sicurezza: meglio darsi da fare.
Iniziando a scrivere questo divertissement estivo, alcuni anni fa, mi era sembrato divertente intitolarlo “guarda chi si rivede” avendo in parte già in mente il sentiero che avrei potuto seguire, e la parte che avrebbe potuto giocare il Sistema Egoico.
Sistema in cui passato, presente e futuro si intrecciano, depositando la loro impronta nei neurogrammi, sistema in cui e con cui incessantemente costruiamo e ricostruiamo il modo di governare il nostro rapporto, la nostra relazione, la nostra interazione con gli ambienti in cui viviamo, simultaneamente, sempre, reale e virtuale.
In questo senso, nella cornice delle relazioni con persone per noi importanti, proprio per la caratteristica di importanza che attribuiamo loro, naturalmente anch’essa frutto della nostra considerevolmente complessa adozione di altrettanto complessi codici neurali, non può che trattarsi di un ri-vedere, di un vedere di nuovo ciò che abbiamo già visto: vedere cioè nell’ambiente reale ciò che avevamo bisogno di vedere, già “visto”, esistente nell’ambiente virtuale, mossi dal bisogno di tenere armonizzati, allineati gli ambienti in cui conduciamo le nostre vite.
Tutto qui? Forse non lo sappiamo dire, ma è probabile che lo sentiamo, sentiamo una sorta di squilibrio tra ciò che sperimentiamo alla “mancata risposta” e questa spiegazione, pur convincente, del tipo “periferica non connessa, verificare il collegamento”, allarmante sì, ma non sufficiente a permetterci di leggere pienamente che cosa ci accade: anche sommando questa ultima “scoperta” alle due precedenti, resta una precisa e netta sensazione di incompletezza.
Non riusciamo a spiegarci in modo convincente almeno una precisa variegatura del complesso insieme di emozioni che marcano l’evento “mancata risposta”: non ho certo la pretesa di sapere che cosa tutti provino, sentano emotivamente in questi casi, le mie osservazioni restano nei limiti della mia esperienza di campo.
Entro questi limiti, a me non è dato trovare un solo riscontro di un solo soggetto che non sia perlomeno infastidito dalla mancata risposta (fastidio è il nome di una emozione), oppure deluso (altra emozione), oppure rattristato (altra emozione)e che, descrivendo il giudizio, la valutazione che può formulare dell’evento, non arrivi, prima o poi, a toccare il tasto della mancanza di considerazione, per dirla in termini cortesi, del non essere parte della fase finale e liberatoria del processo di digestione di colui o colei che non ha dato cenno di risposta, traducendo, per motivi di accettabilità letteraria, un noto modo di dire popolare.
Modo di dire, assai popolare, che trovo più fecondo dell’aulica “mancanza di considerazione”, di tono moraleggiante, per me assai poco piacevole: la brutalità popolare, in questo caso, ci mette meglio sulla pista giusta, meglio di quanto lo faccia il biasimo, che ci costringerebbe a fare un giro più lungo e probabilmente meno agevole.
Il valore
Anche da non sistemici, e usando il comune linguaggio, la conclusione cui necessariamente perveniamo è del tipo: non sono importante per lui/lei, non tanto quanto lui /lei lo è per me, o almeno non tanto quanto io desidero esserlo.
Questa conclusione, da un lato ci riporta alla necessità di allineamento dei nostri mondi, già vista e apprezzata, e dichiarata, giustamente, incompleta, dall’altro apre su un altro genere di bisogni vitali che richiedono perentoriamente, diuturnamente, soddisfazione, e che, tornando al linguaggio comune, possiamo indicare come conferma di valore.
Questo genere di bisogno presenta alcune facce, simultaneamente: richiede di ottenere con sufficiente frequenza le prove del proprio buon funzionamento, i sistemi di cui siamo costituiti sono in ordine e funzionano bene, i codici che usiamo per avere a che fare con ciò con cui abbiamo che fare sono affidabili, il lavoro di continuo allineamento virtuale-reale fornisce riscontro di accettabile successo.
Se non otteniamo prove positive siamo in pericolo, i nostri sistemi di controllo attivano gli allarmi, il pericolo, associato alla mancata risposta, presenta aspetti interessanti, quello indicato dal detto popolare è tra i più interessanti: descrittivamente, letteralmente, è il non fare più parte del nostro interlocutore, non ci può “espellere” perché ci ha già espulsi, mentre noi eravamo altrove e ci occupavamo d’altro, a nostra insaputa.
Il non essere una parte dell’altro, ottenere prova della propria avvenuta espulsione, riscontro della configurazione attuale dell’ambiente reale, è ciò che non si allinea a quella parte del nostro ambiente virtuale che prevede che il nostro interlocutore, soggetto importante per noi, ci tenga nel suo sistema egoico così come noi lo teniamo nel nostro, disallineamento che richiede immediato intervento, di mettere all’opera i nostri codici per mettere, o rimettere a posto le cose.
Quali codici possono essere efficaci per rimettere a posto le cose e riallineare i mondi? Nel cercare la risposta a questa vitale domanda prendiamo necessariamente in considerazione le variabili che possono aver determinato, o contribuito a determinare, il riscontro che abbiamo ottenuto, insomma le possibili cause, le possibili condizioni in cui si trova il nostro interlocutore: siamo relativamente certi di non aver fatto nulla che possa aver “maldisposto” il nostro interlocutore nei nostri confronti, e, oggi cosa abbastanza facile, ci siamo accertati che sia vivo e in buona salute.
La mancata risposta, che è una risposta, dice quel che deve dire: non sei più in me, con me.
L’abbandono
E questa risposta è in un reticolo di connessioni, per ciascuno diverso, complessivamente, spesso simile per alcuni tratti, molto frequente è l’attivazione della connessione con l’abbandono, con l’essere stati abbandonati.
Il nodo dell’abbandono è terrificante, sia per la frequenza con cui questo tipo di esperienza si produce, sia per la molteplicità delle forme che assume; di grande interesse scientifico è come ci abbiamo a che fare, quali codici abbiamo sviluppato per averci a che fare.
Qualche tempo fa, non ricordo su quale dei moderni media, forse addirittura Science, mi imbattei in un articolo che riportava il frutto di una ricerca condotta tra coloro che venivano, disconnessi, rifiutati da un loro contatto sui social media, riscontrando che, per dirla con una similitudine, chi veniva disconnesso, rifiutato provava un dolore superiore a quello tipico del riceve un pugno sul naso.
Come quasi tutti i sedicenti studi sul comportamento umano, si trattava, in verità di una minuziosa raccolta di dati e osservazioni, assente alcuna seria ipotesi eziologica, insomma assenti le spiegazioni, le ragioni che possono essere presentate e accolte, capaci di spiegare perché, come mai, l’essere “disconnessi” da un “amico virtuale” si accompagni ad un dolore intenso come quello che in genere si prova dopo aver ricevuto un cazzotto sul naso... non ricordo di aver mai incassato un pugno sul naso, ricordo di averlo battuto pochissime volte nella mia vita, e ricordo che è dolorosissimo.
Sembra un poco bizzarro, no? è un’”amico” su facebook che, a un certo punto, ti taglia fuori, che sarà mai, un’ “amicizia” virtuale, come quasi tutti dicono, dove virtuale sta, forse anche, per non poi così salda, magari superficiale, magari decisamene fittizia: la ricerca, se non ricordo male, metteva in risalto la relativa indifferenza dei tratti di recenza, superficialità, eccetera, era proprio l’accadimento, nudo e crudo. Tagliato fuori, chiuso fuori.
Se leggiamo la “disconnessione” come una variante delle molteplici forme dell’abbandono, e la mancata risposta come altra variante, abbiamo sempre il compito di spiegarci la dolorosità della reazione, e di verificare meglio la possibile connessione con il valore.
Che l’abbandono sia realmente una minaccia, così come impeccabilmente segnala il nostro sistema nocicettivo attraverso il segnale doloroso, beh, dipende, no? dipende ad esempio da quanto siamo, nell’ambiente reale, “al sicuro”, dalle alternative di cui disponiamo… è che ci siamo messi nella condizione più sfavorevole, abbiamo a che fare con un abbandono compiuto da una persona per noi importante, relativamente impossibile o molto difficile da sostituire.
Facciamo un salto indietro, nel tempo, nel nostro tempo, pochi o molti decenni fa, ma si tratta di decenni, non di milioni di anni, dovremmo riuscire almeno ad immaginare che cosa sia il trovarsi nella condizione di essere abbandonati da piccoli bambini, o piccole bambine, quali tutti noi siamo stati, alle prese con questi giganti semidei, sostanzialmente onnipotenti, che hanno cura di noi, e magari anche in modo solerte quando a noi serve nutrimento, un indispensabile aiuto nel separarci dalle nostre deiezioni, possibili sorgenti di infezioni, di minaccia mortale, protezione e difesa dall’attacco di predatori: senza di loro è morte.
Ben prima di qualunque pensiero, ben prima di qualunque coscienza, ciascuna cellula sa e insegna, attraverso i due metri e mezzo di filamento di DNA, che cosa è e che cosa è bene tentare, ben prima della nostra casuale nascita, lo sa da milioni di anni, lo insegna da milioni di anni: crediamo noi di essere più forti, più potenti di questa onda gigantesca che ha sospinto la nostra specie sulle rive di una provvisoria sopravvivenza, ma pur sempre sopravvivenza?
Certamente sì, e certamente lo siamo… ma non subito, non all’inizio della nostra piccola, insignificante, irrisoria, unica, irripetibile e straordinaria vita, lo possiamo diventare dopo, molto più tardi… e, certo, anche non riuscirci.
Altrettanto evidente che un conto è l’abbandono per un piccolo bambino, una piccola bambina, un conto completamente diverso è ciò che noi “grandi”, noi adulti, siamo capaci di fronteggiare, perbacco, adesso siamo noi quei semidei onnipotenti, beh, insomma, notevolmente ridimensionati, ma capaci di soddisfare i nostri desideri, le nostre necessità… o no?
L’universo in un guscio di noce
Magari qualcuno ha riconosciuto il titolo, un pregevole lavoro di Hawking di un po’ di anni fa, mi piaceva la suggestione della noce, mi raccontavano, decenni fa, che una noce aperta a metà mi avrebbe mostrato il disegno dell’albero che avrebbe potuto diventare nel tempo, e guardavo il gheriglio, ancora nel semiguscio, che stavo cercando di estrarre per assaporarlo, beh, perché no, pareva plausibile.
Divago? Penso di no, uno degli aspetti del “funzionamento dei codici”, negli anni, mi è diventato sempre più importante da decifrare: nessuno ne sa nulla, veramente, i neuroscienziati (alcuni li ho consultati) sono impegnati lungo ben altri filoni, non mi possono aiutare, peccato.
Siamo abituati a considerare i codici come sequenze di istruzioni, 1 e 0, la necessità di saper scrivere codici adatti ai computer quantistici ha cambiato parecchio le cose, non bastano sequenze di 1 e 0, l’esplorazione delle possibilità di costruzione e impiego di elaboratori neuromorfi al servizio di A.I. hanno aperto strade nuove, vedremo che cosa troveranno: per ora occorre contentarci di quel che c’è, e rassegnarci a non disporre di quel che non c’è.
Negli anni, gli elementi che ho raccolto “in corso d’opera” sembrano convergere, indicare in qualche modo che i nostri codici neurali conservano e “rispettano” la storia.
Per ora la mia è solo una congettura, meno ancora di una ipotesi, e, ahimé, non esistono strumenti così fini e precisi da poter impiegare per ottenere prove scientifiche certe, o poco o nulla dubitabili, in mancanza d’altro, me la tengo, meglio del niente che troviamo: è possibile che l’ontogenesi, anche in questo caso, ripeta la filogenesi.
È un principio noto ed accettato tra gli studiosi della vita, anche per noi sembra valere, dal concepimento alla nascita, all’inizio della vita extrauterina, ciascuno di noi ha riprodotto questa indicibile meraviglia, in circa 36 settimane, 270 giorni, 24 milioni di secondi, ripercorriamo una storia di 4 miliardi di anni, da una parte 24 milioni, dall’altra 4 miliardi, rapporto 1 a 170, quasi duecento volte più veloci.
Trovo che sia spesso assai difficile rendersi conto della magnificenza di cui siamo ogni istante testimoni, se questa non viene, in qualche modo, tradotta, in qualcosa di comprensibile per i nostri sensi… il nostro sistema neurale, a quanto sostengono serissimi ricercatori, dentro un solo piccolo e miserabile cervello di circa un chilogrammo di peso, impiega più o meno 120.000 chilometri di filamento neurale, sì quello che si trova tra dendriti e assoni, più o meno quanto ne basta per fare tre volte il giro dell’equatore… a me già impressiona molto la distanza coperta da un volo aereo tra Milano e Londra, fatico a immaginare il giro del mondo, che è molto di più, neanche mille chilometri tra le due città, quaranta volte e rotti di più il nostro equatore.
I due metri e mezzo di DNA sono niente, a meno che non teniamo presente che questo filamento è contenuto in ogni nostra cellula, da 10 a 100 micron, dunque, un micron è un milionesimo di millimetro? giusto? Sì, ho controllato… se trasformassimo ciascun nucleotide in una lettera corpo 11, e accettassimo prudentemente la più semplice leggibilità lineare, come quella di un comune libro, insomma, ci troveremmo con una biblioteca di oltre quarantamila volumi, ciascuno di circa 500 pagine, formato A4… accettando la leggibilità non solo lineare, ma anche e simultaneamente a gruppi di due, o di tre, o di coppie e terne di terzo livello, cosa che pare facciamo senza alcuna difficoltà, come succede nella lettura degli spartiti musicali, il numero dei volumi della nostra biblioteca diventa astronomico.
In una sola cellula, una sola, piccolissima.
Camminiamo, è una bella giornata, una passeggiata fa bene, specie se fatta in posti salubri, sempre meno oggi, ahimè, non abbiamo fretta, a quanto andiamo, 3, 4, magari 5 chilometri all’ora...e un pazzo ci sfiora correndo alla velocità di, dunque, 5 per 200, beh, sembra mille, sì, è 1.000 chilometri all’ora, un milione di metri all’ora, basta poco di più per ottenere il boato dello sfondamento del muro del suono… quanto ci mette per superarci, diciamo per percorrere un metro?
Devo fare i conti, non mi fido, immagino pochissimo, sì, ma il numero mi dà sicurezza, mille chilometri in un’ora diviso tremilaseicento secondi, dunque, quasi quattro millesimi di secondo… no, non ci arrivo, non lo vedo, non sono capace, troppo veloce, l’occhio viene ingannato con sequenze di immagini che si susseguono e poco più di 10 fotogrammi al secondo, non vediamo il fotogramma, vediamo il movimento, 4 millesimi di secondo, io non ce la faccio.
E la rete neurale? Velocità di trasmissione dell’impulso bio-elettrico standard, stimata in 1 millisecondo, 4 volte più veloce del nostro ricapitolare 4 mililardi di anni di storia evolutiva nel corso di una “normale” gravidanza… che cosa può succedere, nella nostra rete neurale, in un solo millisecondo?
Non lo sa nessuno, non abbiamo strumenti e conoscenze sufficienti ad iniziare a descriverlo.
A puro fine pratico, mi è risultato di notevole utilità considerare che i nostri codici neurali conservano la storia della loro costruzione, incarnata nella loro configurazione: da decenni è riconosciuto e accettato che nessun vivente accede alla vita come una pagina bianca, siamo zeppi di istruzioni per l’uso, unica rilevante differenza tra gli umani e le altre specie è la considerevolmente più grande capacità di costruire e scrivere codici nuovi, rispetto alle altre specie.
Ma la nostra natura sistemica “impedisce” la creazione nel vuoto, a quanto ci è dato sapere e conoscere, da tempo immemore accettiamo che natura non facit saltus, la natura, qualunque cosa sia, certamente come astrazione per noi in grado di contenere pressoché tutto, non ammette salti, non presenta discontinuità, ciascun elemento proviene da un altro, è modificazione di qualcosa che c’era prima…
I nuovi “codici” hanno radice nei vecchi, e, quando vengono impiegati, quando viene attivata quella porzione di rete neurale correlata alla loro preparazione ed esecuzione motoria (reale e virtuale) ripercorrono tutta la storia, dall’inizio, da quando erano il riflesso della membrana della ameba che “si ritira” dal contatto con sostanze acide, il comando impartito al flagello dell’eucariote, fino alla configurazione necessaria alla impeccabile esecuzione della Chaconne, dalle Sonate per violino, Opera 2 in Re Minore, BWV 1004, di Johan Sebastian Bach.
Noi che cosa vediamo? Ah beh, vediamo una parte della fine dello spettacolo, ora sto “gustando” una ciaccona eseguita da una violinista giapponese, bravissima, chapeau, ed è già tantissimo.
E dell’abbandono che cosa vediamo mai?
Che cosa riusciamo a sapere, senza sapere di saperlo, ma è lì, sotto il nostro naso, anche “dentro di noi”, e simultaneamente fuori, là fuori, del motivo, delle ragioni che hanno indotto l’altro, il nostro altro, quello che mannaggia non risponde, a non rispondere?
Io Egoista!? E tu allora?
Nessuno può disobbedire all’egoismo geneticamente imposto, al comando di tentare di sopravvivere ad ogni costo, non sono possibili eccezioni: ricondurre la pur infrequente pratica del suicidio a prova ulteriore, e non eccezione alla regola, è relativamente facile, non qui e non ora.
Il Sistema Egoico “contiene” ed organizza tutto ciò che ci serve per sopravvivere, dal suggere il latte materno all’indossare jmmy choo, anche i codici che declinano come è meglio essere egoisti: ogni nostra azione, e quindi ogni nostro codice persegue impeccabilmente il nostro migliore vantaggio, è coerente e consistente con questa finalità, ed è il contenuto inconfutabile del fare del nostro meglio, in ogni istante della nostra vita.
Per riprendere una partizione presentata in un libello di parecchi anni fa, stupido-sprovveduto-pirata-intelligente, le forme dell’ineludibile egoismo di ciascuno sono da considerare come effetti collaterali di altri codici, inevitabilmente adottati poiché quelli, meglio di tutti gli altri, hanno ricevuto sufficiente conferma di riuscire ad ottenere il maggior beneficio per sé.
Suona molto Smith, liberismo e neoliberismo, vero? E abbiamo visto tutti dove l’adozione di quel paradigma ci ha portato e ci sta portando, le denunce e le ammonizioni circa la perniciosità dell’impatto attuale della sopravvivenza della nostra specie sull’ecosistema globale, della continua crescita della disparità, apprezzate da un piccolo pubblico che vorrei chiamare colto, in pratica totalmente ignorate… e anche questo ha una sua ragione precisa, esibisce una solida razionalità, anche se non si tratta di quella razionalità identificata con la condotta intelligente, una delle quattro forme di egoismo razionale, non l’unica possibile… il discorso porterebbe molto lontano, non qui e non ora.
Può suonare paradossale affermare che chi agisce stupidamente, ottenendo svantaggi e danni per sé e per altri, dimostri completa razionalità, ma è relativamente facile condurre questa dimostrazione: ciò che interessa noi, qui, nel limitatissimo ambito dell’indagine relativa allo stress correlato alla mancata risposta, è assumere, dopo aver vagliato accuratamente indizi e prove, dopo esserci resi conto della indicibile complessità da cui traggono origine i nostri codici, che la mancata risposta si costituisca, per l’altro, come la migliore azione possibile, azione che consegue il suo miglior vantaggio.
Da questa parte, liberi noi, in relazione alla ricerca del nostro miglior vantaggio, di giudicare ciò che osserviamo della condotta dell’altro come stupido, sprovveduto o piratesco: con questo non possiamo in alcun modo negare che ciò che osserviamo sia il frutto dell’osservanza del criterio del fare del proprio meglio in ogni istante della propria vita, e che, benché non necessariamente visibili o facilmente comprensibili per noi, esistano solidissime ragioni, conoscendo le quali troveremmo dimostrata la razionalità, la sensatezza di ciò che osserviamo.
A scanso di equivoci, il portone del relativismo becero attraverso cui passano tutte le sciocchezze del mondo è saldamente chiuso: riconoscere la razionalità della stupidità, della sprovvedutezza, della pirateria non implica affatto che esse vengano automaticamente sdoganate e, in alcun modo, autorizzate.
Per i nostri limitatissimi scopi, accogliere la razionalità “immanente” di tutte le forme dell’umano egoismo è condizione che facilita la comprensione del fenomeno che stiamo studiando, aiuta l’individuazione degli antidoti allo stress.
Il nostro Sistema Egoico, egoisticamente, organizza, preserva e conserva ciò che ci serve, ciò che ci è di aiuto nel governare le complessissime interazioni con i nostri ambienti reali e virtuali, in vista della soddisfazione dei nostri bisogni, dei nostri desideri, insomma della nostra sopravvivenza: l’altro ci ha espulsi, possiamo essere sicuri di almeno una cosa, a suo “giudizio” non gli serviamo per avere a che fare con ciò con cui ha a che fare.
Non siamo di aiuto, forse lo potremo tornare ad essere dopo, o molto dopo… forse mai più. Adesso, evidentemente, no.
Colpa
È possibile che tra i pensieri che ci sono arrivati (sì, i pensieri ci arrivano, come tutto il resto, penso) nell’avere a che fare con la mancata risposta abbiamo trovato, al tempo, qualcosa di simile, e la cosa può averci anche lasciato più o meno indifferenti, una roba del tipo, beh, fatti suoi, si arrangi, così è la vita, o addirittura rivolgendo calorosi inviti a recarsi in luoghi che dovrebbero risultare più che sovraffollati, stando a quanta gente ci viene mandata.
Anche se così fosse, lanciato l’invito esorcizzante, non è detto che non ci arrivi anche altro, stando ai miei riscontri diretti e indiretti accade con frequenza assai maggiore di quanto si potrebbe sospettare: che cosa?
La parola colpa è di uso così comune che rischiamo di lasciar passare inosservati i numerosi significati che ne giustificano, se non spiegano, la frequenza d’uso, tra questi il significato di inadeguatezza, di non essere, o essere stati, all’altezza delle aspettative, nutrito dal gemello difettosità, entrambi compatibili e spesso correlati con ciò che accade nelle aule dei moderni tribunali, nei laboratori di ricerca scientifica, nelle sessioni di esame, nei conflitti tra umani, di qualunque ordine, estensione e grado.
Osservazione e ricerca hanno permesso di raccogliere una quantità di dati impressionante, convergenti su un riscontro generale di considerevole interesse: i bambini alle prese con l’abbandono di uno o entrambi i genitori presentano, con rarissime eccezioni, una soluzione comune.
Ciascun “piccolo” della nostra specie, assai presto, sin dai primissimi anni della sua vita, come tutti i viventi umani, ha assoluto bisogno, per il suo buon funzionamento, di allineare ambienti reali e ambienti virtuali, di ottenere prove continue del suo buon funzionamento, di individuare che cosa si collega a che cosa, che cosa causa che cosa, che cosa è conseguenza di che cosa, nel linguaggio comune di “dare senso”, anche di dare senso a ciò che accade ogni giorno, di dare senso all’abbandono, agli abbandoni.
Abbandoni che, non va dimenticato, mai, sono vicini, per i piccoli della nostra specie, alla pura catastrofe, è in gioco la vita.
Quella che di solito chiamiamo colpa immaginaria è una delle forme della predisposizione, plausibilmente geneticamente ereditata, a ricorrere ad una soluzione molto particolare quando affrontiamo problemi insolubili, del tipo di quelli costituiti dall’abbandono da parte dei nostri simili, soprattutto in quella fase della nostra vita in cui la presenza del simile-che-si-prende-cura-di-noi è di particolare rilevanza per la nostra sopravvivenza.
In altri casi, questa speciale soluzione, prende il nome di magia, di pensiero magico, capace di costituirsi come connessione tra elementi altrimenti impossibili da collegare, come “risposta” altrimenti impossibile da ottenere, il discorso ci porterebbe lontano, e in territori impervi, magari un’altra volta.
Colpa porta con sé il riscontro di inadeguatezza, di difettosità, che con enorme frequenza si costituiscono come ragione motivo e causa dell’abbandono: impossibile, per il piccolo bambino, considerare la possibilità che sia il grande, il care taker, quella specie di semidio onnipotente, ad essere colpevole, difettoso, inadeguato, non all’altezza del compito; la predisposizione genetica, plausibilmente, tiene anche conto della necessità di favorire la cosiddetta “socialità”, proteggere appartenenza e permanenza nel gruppo, la ribellione al care-taker incapace risulta meno “vincente” della quiescenza… e poi, statisticamente, meglio un care-taker incapace che nessun care-taker.
E anche la ribellione che abbastanza frequentemente si presenta nel corso della adolescenza non è affatto incompatibile con l’iniziale e prolungata frequentazione della soluzione: è colpa mia.
I contenuti di tale colpa, della colpa immaginaria, raramente presentano difficoltà di reperimento, qualunque dettaglio, aspetto, azione, può facilmente essere integrato: con le parole che vengono conquistate nel corso dello sviluppo sono descritte configurazioni che chissà da quanto tempo si presentano negli ambienti virtuali del bambino, sono brutto, pasticcione, non sono capace di fare questo o quello, non ho risposto come si deve, sono stupido, sgraziato, ho fatto cose proibite, repertorio ricchissimo.
La colpa è, in questi casi, una soluzione magnifica: in questo modo i mondi si allineano, e disponiamo di almeno un modo per avere a che fare con questa ostile configurazione di ambiente reale, ne governiamo almeno il prendere forma, conoscendone la sorgente, in un certo senso la “controlliamo”, non è più qualche cosa che può comparire dal nulla, impossibile da prevedere quanto minacciosa, non è più priva di senso.
Certo il prezzo è alto, siamo manchevoli, difettosi, inadeguati, strutturalmente a rischio costante di essere mandati via, difficile essere apprezzati, anche se possiamo tentare di nascondere la colpa, a volte si riesce, magari anche spesso, magari anche per tempi molto lunghi, finché non ci scoprono siamo al sicuro, nascondere la colpa è un lavoraccio, faticosissimo…
Mettiamo tutto questo in connessione con le considerazioni svolte a proposito della ontogenesi che ripete la filogenesi, del “natura non facit saltus”, certo, congetture, tentativi di spiegarci il perché del dispiacere correlato alla mancata risposta… di nuovo, ben entro il perimetro di fatti e accadimenti cui sono stato diretto testimone, solidi indizi, e, spesso, prove, poco o nulla confutabili, convergono sul confermare che il “dispiacere” (virgolettato, poiché desidero sottolinearne la incredibile complessità, celata sotto un nome, un termine assai comune e appiattito) correlato alla mancata risposta è “nutrito” anche da questo, dal nostro adottare questa soluzione, pre-impostata, di pronto, rapido e sicuro impiego.
Parecchi anni fa mi colpì molto, al punto che la ricordo senza alcuna difficoltà, la replica di un alto dirigente d’impresa, a mio parere uno dei due o tre “veri” (lo so, le virgolette finiscono per annoiare, invoco la clemenza della Corte) General Manager che ho potuto incontrare in decenni di attività professionale, uno dei tanti miti ignoti, campioni di una non abbastanza riconosciuta leadership silenziosa… ebbene, a fronte di un commento ricevuto, con piena evidenza un buon tentativo di battuta umoristica, contenente un blando cenno alla possibilità che egli, General Manager, potesse deludere le grandi aspettative di chi lo circondava, rispose fulmineamente, e con un tono lontanissimo dall’esprimere, simultaneamente, svalutazione del commento, indifferenza, respingimento del significato, difficile per me descriverlo positivamente, c’era fierezza, presa in carico, comprensione, accettazione, riconoscimenti di valore, energia e pacificazione avvenuta: “Lei ha tutto il diritto di essere deluso di me”.
Magnifico il registro vocale, nessuna traccia di gigioneria, di battuta di repertorio provata e riprovata, messa a punto con considerevole impiego di attenzione ed energia, esattamente la sonorità che noi siamo tutti capaci di cogliere, quella sonorità che marca e rende inconfondibile il frutto del migliore tentativo che è stato appena compiuto di trovare, nel mare infinito (o quasi) di tutte le risposte possibili, di tutte le repliche possibile, quella più vera, la migliore verità che si è stati capaci di trovare, e di porgere.
A riprova che esattamente di questo si trattava, per me, già al tempo non del tutto incapace di osservazione e valutazione di accadimenti di questo genere, fu ciò che seguì: nulla.
Esattamente nulla.
Anche alla mia occhiuta e spietata osservazione dei cosiddetti “segnali non verbali”, da parte di questo signore, tra i 55 e i 60 anni, nessun segnale fu generato e inviato, nessun segnale di ammiccamento, di “ci siamo capiti, vero… io sono il DJ, qui dentro sono tutti a me inferiori di grado”, ma solo, e consistentemente, quelli di una quieta e pacificata consapevolezza, curante, per nulla incurante, che diceva senza bisogno di parole, quello che dici è importante, lo è davvero, e, simultaneamente, lo è anche ciò che ho trovato in tanti anni di lavoro, e cioè che è nel tuo pieno e completamente riconosciuto diritto trovarti deluso da me, trovarmi, vedermi, valutarmi come deludente, non all’altezza delle tue aspettative… ed è nel mio pieno e insindacabile diritto prendere decisioni che ti possono deludere, e tradurle in azione concreta, se questo è il miglior giudizio che sono capace di esprimere.
In altre parole, penso più dure, primitive, e crude (e questo è in buona parte l’aspetto straordinario): sono in pace, non sono ostaggio delle tue aspettative, né ora, né mai, né tue, né di chiunque.
Cioè, per noi qui: la via della colpa non è la mia via, non più.
Come ci sia riuscito non saprei proprio dire, al tempo mi sentii felice, senza sapermi spiegare perché, mi ci sono voluti quasi quindici anni per scoprirlo, e anche se adesso so (o credo di sapere, la differenza è risibile) perché, comunque sia sono grato a quel signore: grazie René!
Perché sono grato e felice, anche oggi? Sì, hai indovinato: se ci è riuscito lui, possiamo riuscirci anche noi.
Aiuto
La libertà, completa, il non dipendere da niente e nessuno, e insieme saper e poter provvedere a se stessi, alla propria famiglia, a coloro che amiamo, credo sia un “sogno” che tutti noi, in qualche momento della nostra vita, a volte anche per lunghi periodi, abbiamo nutrito.
Da un po’ di tempo mi succede, con maggiore frequenza rispetto a decenni fa, di sentire giovani uomini e donne, dai venti ai quarant’anni, esprimere con grande energia e convinzione quel desiderio, di vederlo presentato come lo scopo principale e la futura ricompensa dei loro sforzi quotidiani, spesso molto intensi, faticosi, “demanding”… sì, me lo ricordo, ce l’avevo anch’io, tanto tanto tempo fa. E ora non più?
Sì… e no.
L’intreccio delle nostre dipendenze è talmente fitto e diffuso, talmente tante sono le fonti e le sorgenti perenni, da risultarmi sbalorditivo e tecnicamente impossibile anche solo pensare di poter tentare di scioglierle: per restare vivi dipendiamo dalla qualità dell’aria che respiriamo, dell’acqua con cui ci dissetiamo, del cibo con cui ci alimentiamo, degli ambienti in cui viviamo, in misura così cogente da poter riconoscere che da questa forma di “schiavitù” ci è strutturalmente impossibile riscattarci.
E non ci vuole molto a renderci evidente che anche solo per soddisfare questi elementari bisogni dipendiamo da un numero impressionante di altri soggetti umani, dalla perizia e dalla solerzia con cui svolgono il loro lavoro: salendo nella scala di complessità di ciò che può rendere accettabile la nostra qualità di vita, e dei processi attraverso i quali lo possiamo ottenere, la “dipendenza” da altri aumenta ancora, enormemente.
Non dipendere da niente e da nessuno è letteralmente, tecnicamente, impossibile, nutrire aspettative impossibili da colmare non fa per me, e dunque no, se le cose le mettiamo così, no grazie.
Ma sarebbe sciocco e vano fermarsi qui, a quello che sembra essere il brutale riscontro delle condizioni di “realtà” con cui facciamo i conti ogni giorno della nostra vita: sono giovani, ma non sono stupidi, le loro appassionate dichiarazione d’amore per la libertà, di oggi, come le nostre di ieri, vanno capite, comprese, onorate… e sostenute, aiutate.
Ci provo, ogni volta, meglio che so e posso, cerco di capire che cosa ci sia dentro a quel contenitore su cui è applicata una etichetta che riporta la scritta “libertà”, per ciascuno il contenuto è in parte unico, irripetibile, in parte abbastanza simile a quello che ho pazientemente trovato in altri, anche nel mio di tanto tanto tempo fa.
Descrivere compiutamente che cosa ho trovato in queste ricerche è compito superiore alle mie forze, restando veridicente posso indicare, come sintesi, alcuni passi di un celebre monologo, sì, l’essere o non essere di Hamlet, liberi da: “il flagello e le offese del tempo, l’ingiuria degli oppressori, la villania dei superbi, gli spasimi dell’amore disprezzato, le lungaggini della giustizia, l’arroganza dei potenti e gli sfregi che subisce dagli indegni l’umiltà dei meritevoli”.
Che sistemicamente traduco nel prosaico avere a che fare con stolti, sprovveduti, e pirati, con queste tre forme possibili del granitico, geneticamente cogente, egoismo, con gli effetti nefasti, infausti e perniciosi della interazione obbligata con loro.
Chi di noi può garantire di non essersi mai condotto, in nessun momento, rispetto a colui o colei che continua a non rispondere, da stolto, da sprovveduto, o da pirata?
Anche senza entrare nel merito specifico di alcuna interazione “reale”, siamo davvero sicuri di riuscire a riconoscere la cifra del nostro essere, o essere stati per loro… e del loro essere, o essere stati per noi, seguendo in perfetta buona fede il sentiero indicato dal cartello VIP, sono importanti per noi…
Se siamo stati, temporaneamente o definitivamente, abbandonati, a questo punto ci è impossibile non riconoscere la radice di ciò che è accaduto: non siamo di aiuto, ed è del tutto possibile che, dopo aver guardato meglio, con più attenzione, magari anche con “gli occhiali sistemici”, scopriamo che non è affatto un cattivo risultato… certo, magari anche di un effetto collaterale, indesiderato e indesiderabile, della mancanza di conoscenza di come funzioniamo.
Anche aiuto, aiutare, sono parole comuni e presentano intrecci di senso complessi, tutt’altro che semplice sapere e comprendere, ad ogni passo, che cosa aiuti e che cosa no: non necessariamente il riscontro dell’immediato sollievo ottenuto è la prova certa dell’esserci riusciti, anche se riconosciamo che a noi è impossibile tollerare a lungo il dispiacere, il dolore, marcatura inconfondibile di configurazioni di ambienti, reali e virtuali, ostili alla nostra sopravvivenza.
Alla complessità del come, come essere di aiuto, si affianca ed unisce la complessità, da affrontare, del perché, nei suoi due aspetti, per quali ragioni, sulla base di quali ragioni, di quali motivi, nostri e dell’altro, e, non meno importante e cruciale, in vista di che cosa, di quale fine, di quale risultato, e delle possibili o probabili conseguenze che ne possono derivare, o che probabilmente ne deriveranno… per noi e per l’altro.
Complessità che qui indico, astenendomi anche solo dal tentare di approfondire, non credo basterebbe un libro.
Rimedi
Il primo e più importante rimedio, senza alcuna presunzione e ben guardandomi da alcuna millanteria, è quello che abbiamo trovato qui: saperne di più, disporre di una migliore conoscenza del fenomeno, che significa, concretamente, disporre di una migliore conoscenza di come funzioniamo, è il primo e più importante rimedio allo stress da mancata risposta.
Come abbiamo sinteticamente ricordato nella pagina introduttiva di questa sezione, dedicata alla gestione dello stress, stress è il nome di una tensione spiacevole, associata alla nostra detezione di configurazioni di ambienti reali e virtuali ostili alla nostra sopravvivenza: la possibilità di dominarne senso e ragione aiuta a modificare il modo con ci abbiamo a che fare, a ridurre, se non eliminare, la condizione in cui siamo costretti a subirne gli effetti, per accedere a quella in cui, meglio guidati da migliore conoscenza, possiamo almeno iniziare a cercare un rimedio più efficace di quelli che abbiamo a disposizione.
La migliore conoscenza che abbiamo sviluppato qui è di aiuto a graduarne con maggiore accuratezza la nostra valutazione di pericolosità per la nostra sopravvivenza, intesa in senso estremamente ampio, includendo tutto ciò che, per ciascuno di noi, permette di distinguere i diversi livelli di qualità della nostra vita, personale e professionale, e di agire in modo congruente per conseguire e proteggere una qualità di vita soddisfacente.
Ci è ora possibile aver chiaro in “mente” che disponiamo di due linee di lavoro, diverse e complementari: una va nella direzione di individuare, con la maggiore precisione e congruenza possibile, se e come tentare (almeno) di aiutare colui o colei che non ci risponde, accettando che, per ragioni a noi ora ignote, sia del tutto possibile che non ci riusciamo, riconoscendo che “comprendere le ragioni” sia la via maestra per arrivare ad una buona soluzione, ma che non sia affatto detto che riusciremo, vuoi per nostra inabilità, vuoi per la incoercibile determinazione dell’altro a non consentirci di salire a bordo.
L’altra va nella direzione di aiutarci ad aiutare, di cercare e sviluppare una migliore conoscenza di come funzioniamo, più ampia, estesa e profonda di quella che, necessariamente frammentaria, abbiamo trovato qui.
Non che non esistano altri rimedi, questo lo sappiamo già, sono quelli che abbiamo usato sin qui: ma, se siamo arrivati a leggere sin qui, sappiamo anche che non sono del tutto soddisfacenti.
Mancata risposta 2 e mancata chiamata 1 e 2…
Come la mettiamo con la configurazione complementare, con la situazione in cui siamo noi a non dare risposta?
E come la mettiamo con la configurazione della mancata chiamata 1, quella che rintracciamo agilmente attraverso commenti del tipo “è da parecchio che volevo chiamarti”, e, già che ci siamo, con la mancata chiamata 2, la configurazione in cui siamo noi a rimandare e rimandare una chiamata, la composizione e l’invio di un messaggio?
La risposta ce l’abbiamo già.
De te fabula narratur.